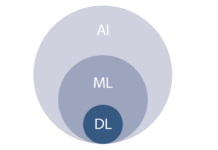Grande interesse ha riscontrato il simposio Goal durante il Congresso Retina in Progress "L'umanesimo e l'innovazione tecnologica in oftalmologia". Particolare valore ha assunto l'intervento della professoressa Luisella Battaglia, docente di Bioetica e Filosofia Morale, per la capacità di accomunare umanesimo e innovazione tecnologia, invitando gli oculisti ad una maggiore attenzione nei confronti del paziente e nel contempo al recupero degli alti valori dell'ars medica. Mi è parso utile ed interessante chiedere alla professoressa Battaglia di proporci il suo pensiero a proposito di umanesimo e medicina.
Danilo Mazzacane
Segretario Gruppo oculisti ambulatoriali liberi (Goal)
L’umanesimo della medicina
La nascita della bioetica negli anni settanta ha posto al centro del dibattito nel mondo della sanità il grande tema della medicina occidentale del nostro secolo, una medicina che punta sempre più sulla tecnologia, sulla perfezione della diagnosi e sempre meno sul rapporto tra medico e paziente. Ciò richiede una sia pur sommaria riflessione sulla natura stessa della medicina il cui oggetto è la conservazione e il ristabilimento della salute e che è quindi, insieme, conoscenza pratica e teorica.
Ma, prima di essere un sapere, la medicina è innanzitutto un rapporto che si instaura tra due persone: colui che cura e colui che è curato. Originariamente la medicina è dunque un dialogo, una reciprocità che non può stabilirsi che nel colloquio singolare della relazione tra due soggetti. Il medico e filosofo Georges Canguilhem sottolinea lungamente nelle sue opere il significato e l’importanza di tale «singolarità». Il colloquio è singolare proprio perché individualizzato, tale da ricominciare ogni volta e quindi non classificabile in quanto relazione tra due individui assolutamente unici.
Già questo rilievo ci pone tuttavia dinanzi a una prima difficoltà. Come è possibile, su tale base, la costituzione di un sapere medico che esige la comparazione e, appunto, la classificazione? La medicina richiede una semeiotica, una nosologia: per curare occorre classificare i sintomi, le malattie, generalizzare le osservazioni e le descrizioni; in altri termini, universalizzare. A quali condizioni può dunque darsi questa universalizzazione delle conoscenze mediche? Il colloquio singolare medico/malato costituisce indubbiamente il prologo, l’apertura della relazione di cura, l’inizio del processo terapeutico.
Relazione, certo, insostituibile, necessaria ma insufficiente: per stabilire la genealogia di una malattia e rilevarne l’itinerario occorrono anche dati oggettivi, interpretabili, quindi generalizzabili. È indispensabile un linguaggio capace di trascendere le particolarità e che sia ben codificato ma, ancora una volta, la classificazione deve essere “interpretata”, rapportata a un individuo, a due singolarità che si esprimeranno e si comprenderanno attraverso un dialogo.
Così intesa, la medicina appare caratterizzata da una dialettica, da una tensione tra singolare e universale che è, insieme, la sua forza e la sua debolezza: la sua forza quando, nella relazione dell’uno e del molteplice, l’uno non scompare a vantaggio del gran numero; la sua debolezza quando la dialettica minaccia di rompersi e il sovra-individuale vuole prevalere sul singolare.
La medicina scientifica ha compiuto straordinari progressi: tecniche sempre più sofisticate consentono al malato di vedersi in tre dimensioni, il medico lo può curare a distanza grazie alla telemedicina, il chirurgo può operare senza toccare direttamente il malato. Progressi innegabili che celano tuttavia un pericolo, quello di vedere l’individuo oltrepassato dal sovra-individuale, ignorato nella sua singolarità dalle esigenze classificatorie.
Che resta allora della relazione originaria, di quel colloquio descritto fin dall’antichità da Ippocrate e dai suoi discepoli dell’isola di Kos? Il malato è solo un “caso”? Sarà curato secondo le norme ottenute attraverso la somma di casi comparabili? Le conferenze di consenso rappresentano, lo sappiamo, un tentativo di universalizzazione delle conoscenze mediche al fine di una cura sempre più efficace.
La buona medicina, pertanto, dovrà mirare a guarire, e quindi essere efficace, ma anche preoccuparsi di essere giusta, rispettando i diritti del malato, e risultare appropriata nell’orizzonte della giustizia, prendendo in seria considerazione l’accesso ai servizi e l’equa distribuzione delle risorse
Un’impresa di grande rilievo ma – e qui si ripropone la domanda – quanto compatibile con quell’ideale medico ippocratico dell’accompagnamento individuale e individuato di ogni malato, con la relazione definita come colloquio singolare? È sempre Canguilhem a ricordarci che la definizione della malattia richiede, come punto di partenza, la nozione di essere individuale. Si tratta di un’affermazione ancora valida? Qual è il posto del malato nella malattia, in una medicina sempre più spinta verso l’universalizzazione e chiamata a divenire una scienza dell’oggetto umano?
Pensiamo a quella vera e propria rivoluzione epocale, che è culminata nell’introduzione del soggetto in medicina, a opera del medico filosofo Viktor Von Weizsaecker, che vede nel malato un soggetto attivo, interprete della sua malattia, in quanto l’infermità è sempre un evento della vita personale. Da qui la convinzione che la medicina debba essere fondamentalmente un’antropologia il cui punto di partenza è la bi-unità dell’uomo.
Contro le chiusure specialistiche, proprie della moderna divisione del lavoro medico, forte è il richiamo verso la confluenza dei diversi saperi e quindi l’appello al nuovo umanesimo della medicina. Oggi si parla di “medicina della complessità” proprio per sottolineare la molteplicità degli aspetti che ineriscono al problema della salute. Dal momento che la salute riguarda l’uomo nella sua totalità, se seguiamo le indicazioni della medicina antropologica è prefigurabile – e auspicabile – un modello bio-psico-sociale che guardi alla persona malata come a un tutto, e quindi, come a un’entità biologica, certo, ma anche psicologica e sociale. Potremmo dire, seguendo le indicazioni dello psicoterapeuta James Hillman, che la cura della malattia è dentro la malattia stessa la quale deve essere integrata nella vita, indagata problematicamente nei suoi aspetti, al di fuori soprattutto degli schemi causalistici che pretendono di dar conto di come certi eventi avvengano senza indagarne il perchè.
La ricostruzione etimologica di alcuni termini chiave è particolarmente utile. Hillman ci ricorda, ad esempio, che medicus richiama il verbo latino mederi che significa “prendersi cura” e che la parola greca therapeia ha anch’essa tale significato: «la sua radice Dher vuol dire portare, sostenere [...]. Il terapeuta è uno che porta e presta attenzione ..».
Per questo, il medico dovrebbe ritrovare la strada verso la visione più antica e integrata della sua vocazione, specie in quelle situazioni difficili della medicina moderna – superspecializzazioni, tariffe, amministrazione ospedaliera – che «mostrano come l’aspetto umano sia caduto nell’ombra».
Oggi, la migliore medicina possibile, la evidence based medicine, rischia di entrare in contraddizione con il dovere incondizionato di cura del singolo paziente, essendo fondata sulla dissociazione progressiva della malattia dal malato che pure resta formalmente al centro delle attenzioni mediche.
Dal momento che la qualità di un intervento sanitario è molto più complessa rispetto al passato, ciò a cui occorre tendere è una riflessione che, se pur basata sullo studio di un caso singolo, dovrà confrontarsi con la necessità di interrogarsi sulle logiche scientifiche, amministrative, socio-economiche, politiche che, da vicino o da lontano, influenzano le condizioni di esercizio della cura.
In estrema sintesi, la buona medicina, pertanto, dovrà mirare a guarire, e quindi essere efficace, ma anche preoccuparsi di essere giusta, rispettando i diritti del malato, e risultare appropriata nell’orizzonte della giustizia, prendendo in seria considerazione l’accesso ai servizi e l’equa distribuzione delle risorse.
La questione di una sintesi equilibrata tra diverse istanze si pone con grande evidenza nel campo della bioetica. Oggi che siamo dinanzi ai complessi problemi della medicina ospedaliera, in cui predomina l’équipe, con i connessi fenomeni di burocratizzazione e di oggettivazione numerica dai risvolti alienanti, è prefigurabile una medicina umanistica in grado di tenere insieme capacità tecniche e carattere morale, accettando la sfida dell’efficienza e della giustizia?
La rivoluzione liberale introdotta dalla bioetica ha al suo centro l’affermazione del principio di autonomia che sancisce il diritto della persona a decidere in merito ai trattamenti medici e quindi anche a rifiutarli, se non corrispondono ai suoi valori e alla sua filosofia della vita.
Nell’ambito del rapporto medico/paziente, “autonomia” e “cura” vengono spesso ritenuti, erroneamente a mio avviso, valori antagonisti: in realtà, all’interno di una bioetica liberale che ponga al centro la relazione tra l’io e il tu, l’autonomia non esclude in alcun modo quel “prendersi cura” che significa attenzione rispettosa per l’altro, le sue esigenze, i suoi bisogni e che testimonia una solidarietà umana fondamentale.
Ma la cultura medica, in quanto luogo privilegiato di interrogazione etica, è preparata a questo rinnovamento, insieme politico e culturale, che non può certo ridursi a una mera questione deontologica? Una definizione di medicina come una forma di relazione interpersonale finalizzata alla cura mi sembra particolarmente congeniale a una bioetica in dialogo con la filosofia e con la medicina antropologica.
Sono queste le linee portanti di una medicina umanistica che, nel suo sforzo di riflettere sul significato filosofico originario dell’idea di cura e di avviare un profondo ripensamento della nozione di terapia, sembra recuperare un’idea antica, quella espressa da Democrito in una lettera a Ippocrate:
Ritengo che la filosofia e la medicina siano sorelle e abitino nella stessa casa; la filosofia libera l’anima dalle passioni, la medicina toglie le malattie del corpo. La capacità intellettiva si sviluppa quando c’è salute, di essa devono preoccuparsi coloro che aspirano al bene; ma se il corpo soffre, la mente non desidera più applicarsi nella virtù; la presenza della malattia offusca terribilmente l’anima e coinvolge nella sofferenza anche il pensiero.